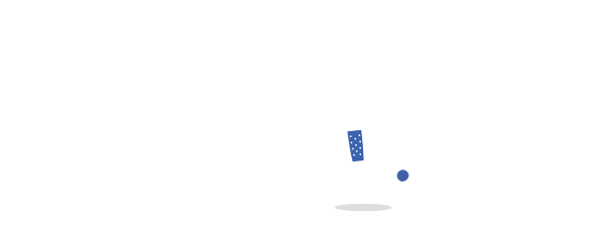Uno, due, tre. Erano i passi che ogni mattina faceva, una volta scesa dal letto, per raggiungere il bagno, guardarsi allo specchio, commentare lo stato dei suoi capelli, disordinati e pieni di nodi, lavarsi il viso e dare inizio a una nuova giornata.
Tre passi grandi, enormi, dai quali non si separava mai. Sul pavimento, in controluce, riflettevano le orme dei suoi piedi nudi e poco importava se avesse freddo, a lei piaceva toccarla, la vita. Calpestarla per sentirsi padrona delle emozioni e non schiava.
Aveva preso l’abitudine di saltare la colazione, lo aveva imparato quell’estate dal suo stomaco chiuso. Per settimane intere, quell’organo contorto e maldestro si era rifiutato di mangiare, riuscendo a convincere persino il resto del corpo che fosse giusto così: desistere dalle tentazioni, così come dai bisogni. Rinunciò a un po’ di chili, ma in cambio tornò ad assaporare il gusto dolce, ma ipocalorico di piacersi.
Non era una che perdeva tempo. Non lo faceva per vestirsi: dall’armadio, infatti, tirava fuori vestiti a caso, scelti per il colore. Una gonna di jeans, un maglione giallo e dei collant bordeaux; un cappello nero, una camicia bianca e un paio di pantaloni scuri; un vestitino che arrivasse a coprire persino le ginocchia. Non seguiva la moda, ma le lancette del suo orologio: sempre in ritardo, sempre di fretta.
Non era una che perdeva tempo. Non lo faceva per truccarsi: le bastava, infatti, coprire soltanto le occhiaie, ma non sempre ci riusciva. Così, senza volerlo, sfoggiava delle mezzelune scure sotto agli occhi che la mettevano in imbarazzo, ma che non nascondeva. Non ne era capace.
Colpa di sua madre, che le aveva sempre insegnato a essere sincera, a essere reale. Forse troppo.
Amava conoscere i fatti della gente, ma non per curiosità. Lei adorava le storie, tutte. Poteva trascorrere ore e ore a sentir parlare le persone, specie quelle che le capitava di incontrare per caso. Una volta, di ritorno da un viaggio, su un aereo si era ritrovata a condividere lo spazio del cielo con un signore di mezza età. Alto, sembrava alto già da seduto, brizzolato, con la ventiquattr’ore sulle gambe e la barba che gli copriva parte del viso, forse la più bella.
Era un avvocato, un uomo che aveva studiato tanto e per cosa poi? Viaggi di lavoro. Si era sposato, aveva avuto dei figli. Tutte cose che fai e di cui poi non godi, un po’ come la macchina nuova che la domenica rimane in garage perché fuori piove.
“Ma chi se ne frega”, pensava dal basso della sua giovane età. “Esci lo stesso e, una volta fuori, o ti ripari o ti bagni”.
Il più delle volte lei si era inzuppata da capo a piedi. Lo aveva fatto ridendo prima e starnutendo dopo. Si era raffreddata puntualmente e, talvolta, aveva persino dovuto rinunciare a quei tre passi la mattina per colpa della febbre che aveva rallentato le sue abitudini.
Testarda, cocciuta, ordinaria. Una ragazza talmente normale che una volta a scuola, durante un compito in classe in cui si doveva parlare di sé, aveva scritto: “Sono colei che c’è, ma non si sente. Colei che c’è, ma non dà fastidio. Se hai l’impressione che sia assente, voltati, sono dietro di te”.
Non le dispiaceva sembrare “invisibile”. Anzi, a volte avrebbe voluto proprio esserlo. Un’ape. No, una mosca. Neppure, un moscerino. Piccolo, piccolissimo da poter andare ovunque senza farsi scoprire. Purtroppo, però, erano lenti a volare rispetto alle distanze troppo grandi per la loro minuscola vita. Così sperava di essere un fantasma. Di quelli che passavano tra le porte, sfidavano i treni senza morire (un’altra volta) e, se volevano, riuscivano a spostare gli oggetti per dar fastidio ai vivi, mettergli paura oppure concedergli la consolazione di sentirsi meno soli.
Lo aveva visto in un film una volta, non lo aveva inventato. Non era brava a inventare, la sua mente era allenata al ricordo. La memoria, poteva ripercorrerla all’infinito, su e giù, avanti e indietro, più volte nella stessa direzione per poi cambiare all’improvviso.
Nella vita, si spostava in macchina. Quando questa non partiva, si spostava in autobus. E quando l’attesa si allungava, faceva strada a piedi. Passava sempre dal mare, che fosse in macchina, in autobus o sui suoi passi. Le dava una desiderata sensazione di libertà, ma non di infinito.
Sebbene fosse sottile la linea di confine tra acqua e cielo, sapeva benissimo che della spiaggia, così come del blu, ci si stancava facilmente. Bisognava salpare o saltare nel vuoto, perché del mare amava la nausea, il dondolo delle onde, il vento che non ha nord né sud, che non conosce ostacoli e soffia fino a perder fiato.
Uno, due, tre. Erano i passi con cui ogni mattina iniziava la sua vita. Lo faceva per ricordarle come camminare, un piede dopo l’altro, non per dirle dove andare.
In fondo, un luogo lo avrebbe sempre trovato. Ovunque è un posto così grande per perdersi e ritrovarsi tutte le volte.